Il termine Hikikomori sta a indicare sia la sindrome, sia il fenomeno sociale, sia le persone che prendono la decisione di isolarsi socialmente. La parola giapponese è stata utilizzata per la prima volta nel 1998 dallo psichiatra giapponese Takami Saito e deriva da “hiku” (tirare indietro) e “komoru” (ritirarsi), e letteralmente significa “stare in disparte” o “isolarsi”.
In linea generale quindi, hikikomori si riferisce a una sindrome che contraddistingue ragazzi e giovani adulti chiusi in casa desiderosi di isolarsi dal mondo esterno. Attualmente questa condizione non è riconosciuta come una vera e propria malattia mentale, tanto che non è ancora stata inserita e riconosciuta nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi alimentari (DSM-5).
Tuttavia è riconosciuto come un fenomeno che causa problemi di salute mentale, con conseguenze a livello socio-culturale, e dunque va analizzato, compreso e risolto, il più delle volte grazie a interventi di psichiatri o psicologi.
C’è cos’è la Sindrome di Hikikomori?
La Sindrome di Hikikomori viene spesso confusa con altre patologie che colpiscono la salute mentale, come depressione e dipendenza da internet. È comunque una condizione che può diventare cronica e minare completamente la qualità della propria vita.
Si tratta quindi di una condizione che colpisce principalmente adolescenti e giovani adulti, che decidono di chiudersi nella propria camera e non uscire di casa per non avere contatti con l’esterno. I primi casi sono stati registrati in Giappone, dove il fenomeno è emerso prepotentemente. Se ne sta parlando anche in Italia, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.
Ovviamente la sindrome può essere riconosciuta grazie al comportamento delle persone: gli individui hikikomori si chiudono nella propria stanza o nella propria casa e rifiutano qualsiasi forma di interazione sociale (social withdrawal). Insomma, l’isolamento sociale è il tratto tipico e distintivo di questa condizione, attraverso il quale la persona evita qualsiasi forma di contatto con il mondo esterno, anche per lunghi periodi di tempo, abbandonando scuola, hobby, amici e lavoro.

Hikikomori: dove nasce è quant’è diffusa nel mondo e in Italia?
Come detto precedentemente, il fenomeno Hikikomori è stato descritto in Giappone verso la fine degli anni Novanta, mentre in Europa è cominciato a emergere prettamente a seguito dei vari lockdown imposti a causa della pandemia da Covid.
Molto probabilmente nel Sol Levante la sindrome di Hikikomori è emersa a causa dell’immobilità economica del Paese, che ha portato molti giovani a non realizzare i propri obiettivi e, quindi, nascondersi in casa per la vergogna a causa di una cultura che fa del lavoro e del successo una pietra miliare dell’esistenza dell’individuo.
Nel corso degli anni 2000 il termine Hikikomori è entrato a far parte anche dell’Oxford English Dictionary, diventando uno strumento importante per definire quelle persone che non avevano una diagnosi di salute mentale, ma comunque presentavano dei sintomi come angoscia, isolamento sociale e depressione.
Al momento non ci sono dati ufficiali su quanti sono gli Hikikomori nel mondo, ma si stima che in Giappone siano più di un milione (l’1,2% della popolazione), mentre in Italia 100mila, secondo quanto affermato ai nostri microfoni dal fondatore dell’associazione Hikikomori Italia Marco Crepaldi.
Leggi anche: Cibi contro la depressione: cosa mangiare per combatterla
Chi sono gli Hikikomori e come si vive con questa sindrome?
Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Veronesi, gli Hikikomori sarebbero adolescenti e giovani adulti compresi tra i 14 e i 30 anni d’età, principalmente maschi (70-90% dei casi), sebbene non avendo dati ufficiali le statistiche potrebbero essere sottostimate, anche per le donne.
A oggi li possiamo riconoscere come individui che si isolano socialmente, ma questo tratto è comune anche ad altri disturbi che colpiscono la salute mentale. Il problema di fatto è l’assenza di un concetto standardizzato attraverso manuali diagnostici dedicati. E questo può generare fraintendimenti o dati diversi in base alle ricerche effettuate.
In base a quanto riporta The Japan Times, citando i dati del 2019 del The Cabinet Office, in Giappone sono stati stimati 1,15 milioni di individui hikikomori, di cui 613mila in una fascia d’età compresa tra i 40 e i 64 anni: tra queste, ci sarebbero persone ritirate dalla vita sociale da circa 30 anni, tanto da aver reciso i legami anche con i propri genitori.
Ma quanti casi di hikikomori ci sono in Italia? Anche qui, la risposta è complessa, poiché non esistono statistiche ufficiali in merito. Secondo le stime diffuse da Hikikomori Italia, sarebbero 100mila. Ciò testimonia comunque che tale sindrome non è solo una questione orientale, ma riguarda anche altri paesi.
In un sondaggio promosso, i cui risultati sono stati pubblicati nel libro “Hikikomori, i giovani che non escono di casa“, lo psicologo Marco Crepaldi avrebbe dimostrato che nel Bel Paese questa condizione sarebbe diffusa soprattutto tra i giovani: dopo aver coinvolto 288 madri e padri dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori Onlus, l’87,85% del campione ha dichiarato di avere un figlio in isolamento sociale di sesso maschile, la maggior parte di essi risulta chiusa in casa da oltre 3 anni e ha un’età media intorno ai 20 anni.
Quali sono i sintomi della Sindrome di Hikikomori?
Visto che non ha una definizione specifica, la diagnosi risulta complicata, e dunque anche classificarne i segni. Un altro impedimento è dato dal fatto che la condizione fin qui descritta può essere associata ad altre patologie – lo stesso isolamento sociale è un sintomo che può essere trovato in altre condizioni psichiatriche. Per fare qualche esempio:
- schizofrenia;
- depressione;
- disturbo d’ansia sociale;
- disturbo dello spettro autistico.
Insomma, parlare in senso stretto di Hikikomori è abbastanza difficoltoso. Al momento sappiamo che per parlare di questa sindrome, bisogna riconoscere nell’individuo:
- una condizione di completa alienazione sociale da almeno 6 mesi (e può durare per anni) che li porta a dipendere economicamente da altre persone (spesso i genitori o i familiari);
- uno stile di vita che ruota dentro le mura domestiche e senza alcun contatto esterno;
- un esordio precedente ai 30 anni d’età (sebbene non mancano esordi anche in individui over 40 o in persone anziane);
- la disforia;
- il rifiuto di contatti sociali così marcati da decidere di non andare a scuola o a lavoro;
- la ridotta concentrazione;
- la perdita di motivazione.
Tutti questi comportamenti e sintomi possono causare effetti duraturi per tutta la vita, come:
- aumentare il peso dello stato depressivo;
- alimentazione non sana;
- dipendenza da internet (in quanto non è una causa, ma una conseguenza);
- scarsa attività fisica;
- stress costante;
- l’inversione del ritmo sonno-veglia: i pazienti tendono a dormire di giorno e dedicano le proprie attività alla sera e alla notte;
- perdita di contatto con la realtà;
- ansia e disturbi depressivi.
Leggi anche: Depressione giovanile: cos’è, sintomi, cause e cura

Quali sono le cause e i fattori di rischio della sindrome di Hikikomori?
Non esiste una causa specifica che porta gli individui all’hikikomori, tuttavia secondo gli esperti vi sarebbe una concatenazione di fattori diversi tra loro, che lo descriverebbero come un fenomeno multidimensionale. In particolare, va posta molta attenzione alle condizioni biopsicosociali che nell’individuo possono far emergere comportamenti riconducibili alla Sindrome di Hikikomori.
Comunque, tra i fattori di rischio possiamo individuare:
- fattori ambientali (le dinamiche familiari: genitori troppo iperprotettivi oppure che trascurano i propri figli: le dinamiche extrafamiliari: persone vittime di bullismo);
- fattori individuali o caratteriali (traumi o personalità introversa);
- fattori socioculturali (il cambiamento nel modo di comunicare con le persone con l’avvento di Internet, le aspettative di realizzazione sociale o la severità del sistema scolastico).
Ciò che emerge chiaramente da alcuni studi è che esperienze traumatiche come vergogna, senso di inadeguatezza e sconfitta, spesso legate al mondo del lavoro e della scuola, sono la causa più comune che porta le persone a diventare hikikomori. Tutto ciò spesso è determinato dalla cultura presente nel Paese in cui avviene questa trasformazione, soprattutto se si vive in una società che spreme le persone a competere tra loro.
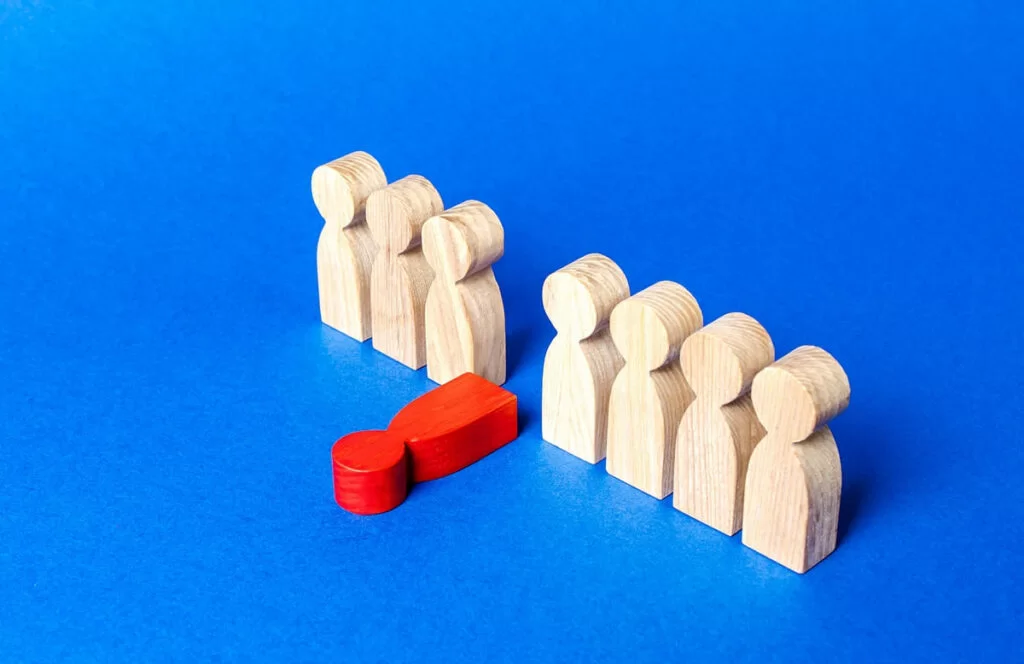
Come uscire dalla sindrome di Hikikomori?
Come ogni condizione esistente, il singolo caso va trattato da paziente a paziente e bisogna sempre affidarsi a uno specialista. In generale può essere richiesto un intervento terapeutico con lo scopo di riportare la persona all’interno di una cerchia sociale, rompendo l’isolamento e riequilibrando l’attività dell’individuo nella società. Al fine di percorrere questa strada, potrebbe essere richiesto un ricovero ospedaliero, la psicoterapia o alcune cure farmacologiche.
Come comportarsi con un Hikikomori?
Finora questa sindrome è diffusa particolarmente tra adolescenti e giovani adulti, e questo può creare una frattura nella relazione con i propri genitori, da cui possono fortemente dipendere economicamente.
In genere, le figure genitoriali sono portare a rispondere in modo duplice: iper-proteggendo i propri figli, impedendogli di fare i propri errori e dunque creare in loro un’evoluzione, oppure iper-criticandoli, evitando di comprendere e consapevolizzare il loro malessere.
La relazione genitore-figlio è nevralgica per permettere all’individuo di superare questa sindrome, e per portarla avanti è necessario lavorare contemporaneamente su entrambi i soggetti chiamati in causa:
- il genitore può cercare un canale comunicativo con il proprio figlio, abbandonando ogni atteggiamento giudicante o coercitivi;
- valutare l’aiuto di uno psicologo o di uno psichiatra.
Leggi anche: Maladaptive daydreaming: cos’è il disturbo da fantasia compulsiva
